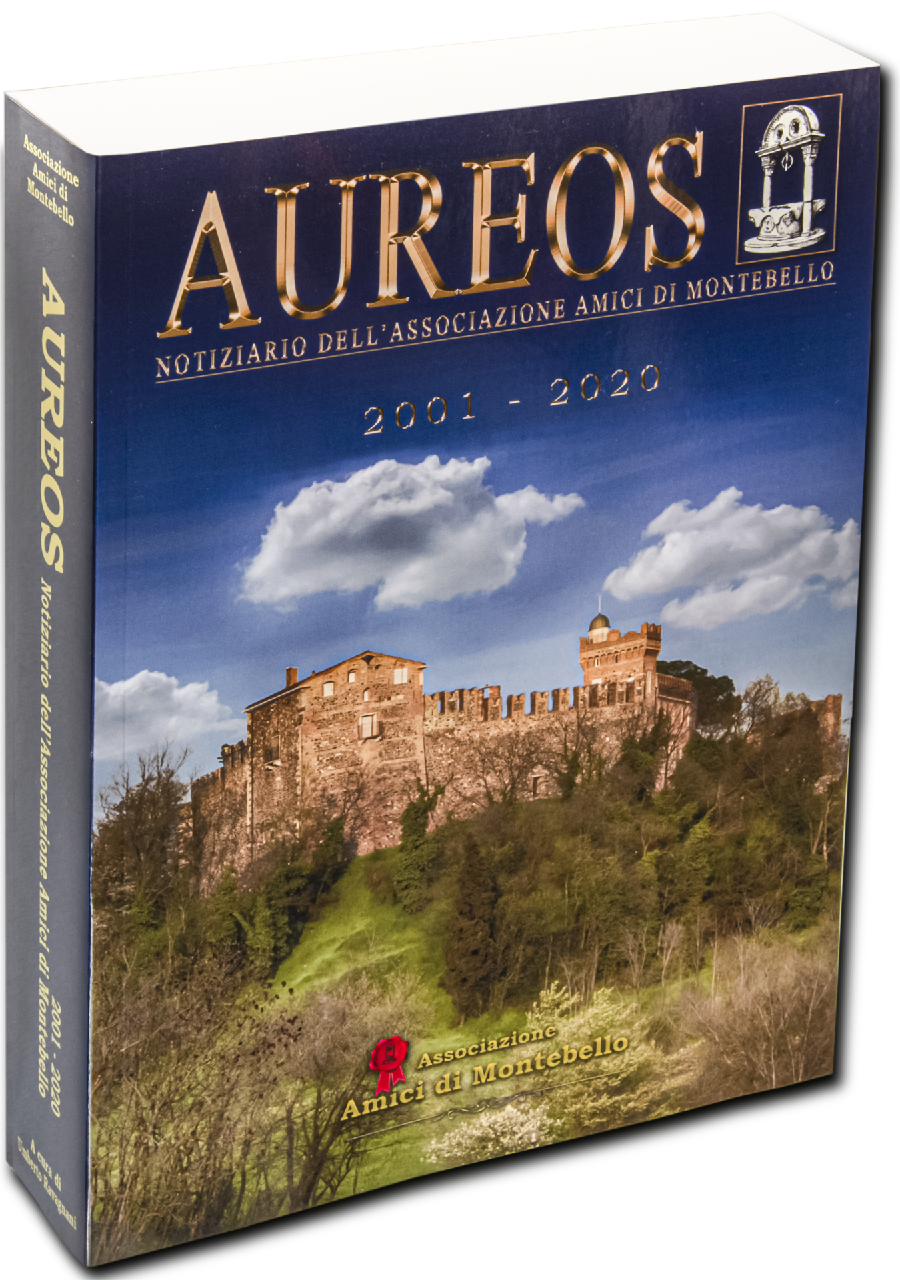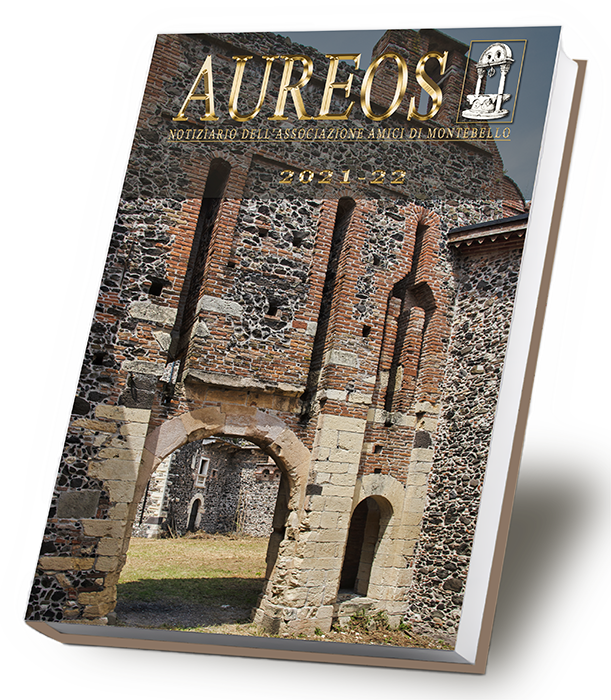[400] UNA CURVA MORTALE
Una cronaca di tragedie e speranza

Così scriveva il Corriere della Sera del 7 ottobre 1967 in riferimento alla strada statale 11 all’altezza della cosiddetta “curva de Maieto“, a Montebello Vicentino:
« Una curva mortale. Ippocastani scortecciati, paracarri divelti o spezzati, autovetture accartocciate, autocarri ribaltati, autotreni che riversano Il loro carico sulla strada: Questi e altri incidenti spesso mortali si ripetono con sconcertante frequenza nella tristemente famosa curva dl Montebello Vicentino. Intervento dl autoambulanze, carri attrezzi, polizia, carabinieri col solito rito dei rilievi constatazioni, Interruzioni, misure, documentazioni fotografiche: ma ben altre misure si richiedono. Anzitutto quelle elementari di prevenzione rafforzando la segnaletica. Quanto agli autisti che si accingono ignari ad abbordare la curva, specie se viscida per la pioggia, non è da addebitare loro Integralmente lo scarso uso di prudenza. I paracarri, scrupolosamente rimpiazzati dopo ogni incidente, persistono inconsapevoli ad assolvere all’ingrata e assurda funzione di baluardi invalicabili e micidiali. E gli incidenti si ripetono con angosciosa allucinante monotonia sulla curva di Montebello Vicentino detta ormai “la tomba degli autisti”. »
Nel 1920, Igino Peruffo, sindaco di Montebello Vicentino dal 1920 al 1923, decise di modernizzare le infrastrutture del paese, inclusa la costruzione della circonvallazione. Questo progetto, sebbene nato con buone intenzioni, si rivelò col tempo una trappola mortale. La cosiddetta “curva de Maieto” situata nei pressi dell’ex ristorante “Alla Stazione”, di Cesare Maggio, divenne famigerata per la sua pericolosità.
Arrigo Peruffo, figlio dell’ex sindaco, in un’intervista rilasciatami nel 2014, ricordò come suo padre avesse avuto grandi speranze per la circonvallazione. “Mio padre voleva migliorare la viabilità e ridurre il traffico nel centro del paese,” disse Arrigo “non poteva immaginare che quella curva sarebbe diventata una delle più pericolose della regione.”
Gli incidenti su quella curva rovinosa sono stati così frequenti da diventare un triste rito quotidiano per i soccorritori locali.
Le immagini dei disastri stradali erano quasi sempre le stesse: auto accartocciate, camion ribaltati, carichi sparsi sull’asfalto. E sempre, a ogni incidente, il solito rituale: intervento di ambulanze, carri attrezzi, polizia e carabinieri. Ma la vera tragedia era l’inevitabilità di questi eventi.
Molti fattori contribuirono a rendere quel tratto di strada a gomito così pericoloso. La segnaletica inadeguata, la scarsa visibilità nelle giornate di pioggia e la manutenzione insufficiente della strada erano solo alcune delle cause. Ma forse il problema più grande era la conformazione stessa della curva: stretta e con un angolo tale da sorprendere anche gli autisti più cauti.
Nel corso degli anni, vari tentativi sono stati fatti per migliorare la sicurezza della curva. Furono installati paracarri e segnali di avvertimento, ma nulla sembrava sufficiente. Ogni volta che un incidente accadeva, i paracarri venivano sostituiti, solo per essere nuovamente distrutti poco dopo. Le autorità locali erano impotenti di fronte a quella che sembrava una maledizione.
Solo a partire dagli anni ‘80, dopo altri tragici incidenti, le autorità regionali decisero di intervenire in modo più deciso. Venne ridisegnata la curva, allargata la strada e migliorata la segnaletica. Sebbene questi interventi avessero ridotto il numero di incidenti, la reputazione della “curva mortale” rimase.
Oggi, la “curva di Maieto” è ancora lì, testimone silenziosa di decenni di tragedie. La strada è più sicura, ma il ricordo di tutte le vite perse è ancora vivo nella memoria della comunità.
La storia della curva di Montebello Vicentino è un monito su come le buone intenzioni possano portare a conseguenze inaspettate e tragiche. È anche un esempio di come la determinazione di una comunità possa portare a cambiamenti significativi. Mentre guardiamo al futuro, è essenziale ricordare le lezioni del passato e continuare a lavorare per strade più sicure per tutti.
Umberto Ravagnani
FONTI: Intervista ad Arrigo Peruffo nel 2014 e Corriere della Sera del 7 ottobre 1967.
FOTO: La famigerata “curva de Maieto” in una cartolina postale degli anni 40 del Novecento (collezione privata Umberto Ravagnani).
Se hai FACEBOOK e l’articolo ti ha soddisfatto metti MI PIACE 
Oppure lascia un commento qui sotto…





 « Sono Elisa Longarato e ringrazio Elena Bellina (New York University) e Giorgia Alù (Sidney University) per l’invito. È un onore per me partecipare a questo incontro. Mi scuso in anticipo per il mio pessimo inglese.
« Sono Elisa Longarato e ringrazio Elena Bellina (New York University) e Giorgia Alù (Sidney University) per l’invito. È un onore per me partecipare a questo incontro. Mi scuso in anticipo per il mio pessimo inglese.


 Tuttavia, una catapecchia adiacente all’abitazione del Vicario rimaneva ostinatamente in piedi, compromettendo la bellezza e la funzionalità della nuova piazza. Solo nel giugno del 1683, la Vicinia comprese la necessità di una piazza più ampia e decise finalmente di demolire la vecchia costruzione3. La demolizione avvenne a dicembre dello stesso anno, dopo il consenso dei deputati di Vicenza
Tuttavia, una catapecchia adiacente all’abitazione del Vicario rimaneva ostinatamente in piedi, compromettendo la bellezza e la funzionalità della nuova piazza. Solo nel giugno del 1683, la Vicinia comprese la necessità di una piazza più ampia e decise finalmente di demolire la vecchia costruzione3. La demolizione avvenne a dicembre dello stesso anno, dopo il consenso dei deputati di Vicenza




 Il “Quartier grande” di Montebello, con tre stalle per 55 posti, richiedeva maggior impegno. Le stalle piccole erano situate di fronte alla Strada Regia, mentre “lo stallone” si estendeva verso l’argine del Chiampo. Le camere erano per lo più al primo piano sopra le stalle. Il “quartieretto” disponeva di due stalle per un totale di 12 posti e 11 stanze tra camere e salette. Questo assetto risulta da un inventario del 1715. Gio.Maria Guelfo fu uno degli appaltatori più longevi, gestendo i quartieri di Montebello dal 1692 al 1712, nonostante le difficoltà causate dalle alluvioni del 1692, 1702 e 1710. Durante il suo mandato, Guelfo fu accusato di appropriazione indebita e negligenza nella manutenzione, portando a una lunga controversia con l’amministrazione di Vicenza. Egli replicò sostenendo che le truppe tedesche di passaggio nel 1705 non avevano pagato il fieno e avevano sottratto foraggio. Dopo l’alluvione del 1710, soldati del capitano Carrara avevano anche rubato denaro a suo figlio. Il successore di Guelfo, Nicolò Perana, dovette affrontare simili difficoltà nel far rispettare i pagamenti da parte dei soldati. Nonostante questi problemi, il ruolo del quartiermastro rimase cruciale per garantire il funzionamento delle caserme e il supporto logistico alle truppe, contribuendo così alla difesa del territorio della Repubblica di Venezia.
Il “Quartier grande” di Montebello, con tre stalle per 55 posti, richiedeva maggior impegno. Le stalle piccole erano situate di fronte alla Strada Regia, mentre “lo stallone” si estendeva verso l’argine del Chiampo. Le camere erano per lo più al primo piano sopra le stalle. Il “quartieretto” disponeva di due stalle per un totale di 12 posti e 11 stanze tra camere e salette. Questo assetto risulta da un inventario del 1715. Gio.Maria Guelfo fu uno degli appaltatori più longevi, gestendo i quartieri di Montebello dal 1692 al 1712, nonostante le difficoltà causate dalle alluvioni del 1692, 1702 e 1710. Durante il suo mandato, Guelfo fu accusato di appropriazione indebita e negligenza nella manutenzione, portando a una lunga controversia con l’amministrazione di Vicenza. Egli replicò sostenendo che le truppe tedesche di passaggio nel 1705 non avevano pagato il fieno e avevano sottratto foraggio. Dopo l’alluvione del 1710, soldati del capitano Carrara avevano anche rubato denaro a suo figlio. Il successore di Guelfo, Nicolò Perana, dovette affrontare simili difficoltà nel far rispettare i pagamenti da parte dei soldati. Nonostante questi problemi, il ruolo del quartiermastro rimase cruciale per garantire il funzionamento delle caserme e il supporto logistico alle truppe, contribuendo così alla difesa del territorio della Repubblica di Venezia.
 La familia Maltraverso lasciò un’impronta significativa anche nella Chiesa. Guido Maltraverso, figlio di Gilberto, divenne vescovo di Ferrara nel 1304 e fu autore di opere teologiche. Nicolò Maltraverso fu nominato vescovo di Reggio Emilia e amministratore di Vicenza nel 1213, mentre Giordano Maltraverso fu vescovo di Padova nel 1214 e inquisitore sotto papa Onorio III. Angelo Maltraverso, infine, fu vescovo di Ferrara e patriarca di Grado, svolgendo delicate missioni per il papa. La presenza costante dei Maltraverso nei ranghi della Chiesa testimonia il loro impegno nel sostenere e diffondere la fede cristiana, oltre a rafforzare la loro posizione sociale e politica.
La familia Maltraverso lasciò un’impronta significativa anche nella Chiesa. Guido Maltraverso, figlio di Gilberto, divenne vescovo di Ferrara nel 1304 e fu autore di opere teologiche. Nicolò Maltraverso fu nominato vescovo di Reggio Emilia e amministratore di Vicenza nel 1213, mentre Giordano Maltraverso fu vescovo di Padova nel 1214 e inquisitore sotto papa Onorio III. Angelo Maltraverso, infine, fu vescovo di Ferrara e patriarca di Grado, svolgendo delicate missioni per il papa. La presenza costante dei Maltraverso nei ranghi della Chiesa testimonia il loro impegno nel sostenere e diffondere la fede cristiana, oltre a rafforzare la loro posizione sociale e politica.